Cerca

- GIUSEPPE PROVENZANO
- MARTINA ESPOSITO
- ANTONINO BLESI
- STEFANO NICASTRO
- ALESSANDRO VAILATI
- STEFANO VALLI
- MARY PELLEGRINO
- CRISTIANO CARENZI
- ANDREA C. SONCINI
- DARIO LOPEZ
- DANIELE CATALUCCI
- ELISA AIRAGHI
- JACOPO BOZZER
- LAURA FLOREANI
- LA REDAZIONE
- PAOLO TOCCO
- MATTEO MINELLI
- ROBERTO BRIOZZO
- GIOVANNI CAPPONCELLI
- VLAD TEPES
- EVIL MONKEY
- LEO GIOVANNINI
- MISCELLANEA (AUTORI VARI)
- MASSIMILIANO MANOCCHIA
- LUCA FRANCESCHINI
- NICOLA CHINELLATO
- STEFANO GALLI
L’esordio come scrittore per Alberto Rezzi avviene nel 2018 e da allora l’aggettivo irrefrenabile risulta un eufemismo per descrivere ciò che ha prodotto, ma soprattutto quanto abbia innalzato il livello qualitativo dell’arte del parlare di musica, in un modo nuovo e completamente diverso rispetto a prima.
Ammetto di essere stato il primo a domandarmi cosa si potesse ancora discettare su Clapton, all’epoca dell’uscita de “La filosofia di Eric Clapton. Il blues come sapere dell’anima” per poi rimanere a bocca aperta, rimangiarmi quanto detto dopo aver letteralmente divorato il libro…
E, come accennato all’inizio, da lì il ragazzo di Torino, redattore, editor e traduttore, non si è più fermato, confezionando una serie di pubblicazioni sbalorditive, ricche di inventiva e sorprese, di cui avremo ampia possibilità di parlare durante quest’intervista che capita in un momento molto particolare, tra la gioia per l’uscita di un’altra perla di questo autore, che dimostra con smaccata e smarcata autorità la crescita in un percorso sempre più legato alla filosofia applicata alla musica, e, viceversa, la sofferenza per un’improvvisa perdita legata proprio a questo tragitto.
L’emozione per la realizzazione de “La via mistica di George Harrison. Musica, Maya, risveglio” e il dolore per la scomparsa di Pat Martino rappresentano un po’ la metafora della vita, spesso insita nella concezione filosofica: la felicità è qualcosa a cui tendere, ma risulta irraggiungibile per l’essere umano. Nel momento in cui arrivi al culmine della ricerca e analizzi il personaggio più ascetico, perdi quello più sentito e voluto della collana, a cui eri legato profondamente. Hai pure avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente e ciò non ha fatto che accrescere l’immensa stima che provavi per lui. Un musicista, definito “uno dei cinque migliori chitarristi di tutti i tempi”, ma prima di tutto un uomo con un percorso unico e, incredibilmente, tuttavia, perfetto sconosciuto al vasto pubblico, non trovi? Fortunatamente opere come la tua contribuiscono al suo riconoscimento.
La recente scomparsa di Pat Martino ha naturalmente commosso me come molti suoi fan in tutto il mondo, ma la cosa straordinaria – che in piccola ma significativa parte ho toccato con mano quando l'ho incontrato dopo un suo concerto – è la scintilla che l'uomo Pat ha fatto scattare in chiunque lo abbia incontrato, anche solo per pochi minuti. Mentre scambiavo qualche parola con lui cercando di parlargli del libro che stavo preparando sulla sua “filosofia”, ho provato non solo emozione, ma una vera e propria vibrazione che mi ha lasciato senza fiato. Esseri umani così se ne incontrano di rado, e mi ritengo fortunato ad aver avuto la possibilità di scrivere su di lui, sulla sua vita, la sua musica e il suo modo di guardare all'esistenza: per questo ringrazio la casa editrice Mimesis che ha scommesso sulla pubblicazione pur trattandosi – ahimè – di un artista non così noto in Italia al grande pubblico.

Tutto è cominciato con Clapton. La sua biografia è ricca di successi e avvenimenti tragici, ma tante rockstar hanno vissuto vite movimentate, quindi perché proprio lui? La tua opera è stata apprezzata anche all’estero, tanto da essere finita sul comodino dei fan più accaniti e avere ricevuto richieste di traduzione in lingua inglese. Il libro è arrivato pure nelle mani di persone nell’entourage di Slowhand, che hanno particolarmente gradito l’originalità dell’approccio. Chissà se è finito perfino nella collezione personale di Eric…
Perché proprio Eric? Beh, anzitutto perché per anni mi sono nutrito della sua musica e del suo stile chitarristico, studiandone in maniera quasi ossessiva assoli, fraseggi, vibrato... Nel frattempo la sua autobiografia, letta e riletta, mi ha catturato mentre stavo attraversando un momento non facile: mi sono letteralmente immerso nell'ascolto di canzoni e interpretazioni, penso a brani come "Sinner's Prayer", "Double Trouble" o "Five Long Years". Quella potenza espressiva nella voce come lungo i tasti della chitarra... Mi ci sono aggrappato come a una zattera in mare aperto.
Così, più approfondivo la sua storia di cadute e rinascite, più percepivo in filigrana una “radice” filosofica, un “sapere dell'anima”, come lo chiama Maria Zambrano, che ha a che fare con la difficile scoperta della propria identità e soprattutto con l'ancor più difficile fedeltà a questa identità. Si tratta di un sapere fragile, mai definitivo, fondato su un ordine musicale, non architettonico. Questo radicamento esistenziale per Clapton è stato il “blues” come attitudine e linguaggio espressivo prima ancora che come genere. Un'attitudine che prorompe e scompare, che torna prepotente e poi si eclissa di nuovo, ma che non per questo perde valore. Penso in particolare a due “bivi” (o crossroads) particolarmente eloquenti in questo senso come lo storico Beano album con John Mayall di metà anni Sessanta e un album di sole cover blues come From the Cradle del 1994. In mezzo, trent'anni di vita e di pressoché ininterrotta carriera, come un cerchio che si chiude e nel suo chiudersi dice molto anche di quello che sarebbe venuto dopo…
È un libro a cui devo molto e l'interesse che ha suscitato è stata, per un esordiente come me, una straordinaria e inattesa sorpresa.
L’infatuazione per il chitarrista inglese non si placa, anzi scrivi praticamente di getto “Clapton e Layla. Un album, una storia, un poema d’amore rock”. Qui il taglio è completamente diverso e, guarda caso, il protagonista intreccia la sua storia con Hendrix e, ovviamente, Harrison.
Finora mi è quasi sempre successo che, terminato un libro, mi restasse la curiosità e la voglia di indagare più a fondo alcune cose che avevo dovuto lasciare ai margini durante la fase di ricerca e stesura. Per Layla è stato esattamente così e il cinquantesimo anniversario rappresentava il pretesto ideale per rimettermi al lavoro su quel materiale. La vera ragione, però, almeno per me, per cui scrivo è entrare a fondo in un vissuto, un'esperienza o una storia che mi riguarda: nel caso del doppio album Layla and other assorted love songs, potevo disporre di 14 tracce piene di incroci, rimandi, vicissitudini che avevano tutte a che fare con un unico grande tema: una passione così travolgente da diventare ossessione e prorompere in arte. Ho studiato a fondo l'antico poema persiano da cui Eric trasse ispirazione, Layla e Majnun, scoprendo come molte canzoni di quel disco ne fossero intrise.
Questa è stata la miccia, unita al fatto che volessi dare al tutto un taglio narrativo: perché quell'album sanguina, piange, si contorce insieme a te mentre lo ascolti, e doveva essere reso con un linguaggio vivo. Inoltre, volevo che fosse un racconto corale e che si nutrisse di tutti gli intrecci artistici e umani che Clapton visse negli anni che portarono a quell'opera unica: interi capitoli sono infatti dedicati ad amici e compagni di strada come gli Stones, Hendrix, Delaney and Bonnie, Bobby Whitlock, Dr. John, i Dominos, oltre ad Harrison naturalmente… Al di là della nota vicenda legata a Pattie, quella tra George ed Eric è stata una straordinaria storia d'amicizia e di collaborazioni artistiche, non da ultima la forte partecipazione dei Dominos alle registrazioni del triplo All Things Must Pass harrisoniano del 1970, uscito quasi in contemporanea a Layla.
Le illustrazioni di Laura Ciriello sono davvero indovinate e la prefazione di un fan particolare, quel romantico gigante della chitarra che di nome fa Maurizio Solieri, conferma la bontà del tuo lavoro. Come sono nate queste formidabili collaborazioni?
Avevo già scritto alcune parti e creato la struttura del libro quando lo proposi ad Arcana, storica casa editrice musicale italiana. Era piena estate 2019. Non mi aspettavo una risposta necessariamente positiva, né tantomeno celere. Invece pochi giorni dopo il progetto venne approvato, con data di uscita prevista fine gennaio 2020. Naturalmente non mi sembrava vero, anche se dati i tempi strettissimi si trattava di ultimare il tutto in pochi mesi. Così, d'istinto quello stesso giorno scrissi a Maurizio Solieri, del quale avevo visto su YouTube alcune versioni di Layla e che sapevo essere un grande fan di Eric. Lo feci non senza una notevole dose di incoscienza ed emozione, visto che sono cresciuto, come molti della mia generazione, con il suono della sua chitarra a dare struttura e corpo a molte canzoni amate e ascoltate a ripetizione.
Quando anche lui dopo pochissimo tempo mi rispose per dirmi che avrebbe scritto volentieri la Prefazione, capii che rendere omaggio a quell'album era stata una buona idea: si tratta di una storia talmente vera e personale da essere diventata leggendaria. Mi piaceva però che fosse costellata dei volti dei protagonisti così com'erano in quel periodo: nel caso di Eric e George, due ragazzi di 25 e 27 anni. Da qui l'idea di chiedere di illustrarlo alla bravissima Laura Ciriello, che avevo conosciuto – a proposito di incroci – durante una presentazione in radio de La filosofia di Eric Clapton. La voce narrante che ho usato per il testo è quella di una donna, e non poteva che essere una ragazza a dare un volto ai protagonisti, compresi Jimi, Duane Allman e ovviamente lei, la “musa”, Pattie Boyd.
Solieri è stato chitarrista storico di Vasco Rossi per parecchi anni, contribuendo, anche a livello compositivo, a creare alcune delle più belle pagine della musica dell’artista di Zocca. Recentemente proprio il Komandante ha dichiarato: “Si crede in una verità per sopravvivere e per cercare quel continuo essere in equilibrio nell’inferno della mente”. Può essere la musica tale verità? Si intreccia così nuovamente il discorso tra filosofia e musica?
Forse usiamo troppi nomi per le cose, non possiamo farne a meno; ma se ci penso bene per me non esiste esattamente un confine, se non linguistico (appunto), tra ciò che muove un filosofo o un musicista a esprimersi. Come diceva Sgalambro, «comunicare è da insetti. Esprimerci ci riguarda».
Si tratta sempre della vita, dello stare nel mondo, del cercare risposte al nostro posto in un universo che così poco conosciamo o, come dice Vasco, trovare “un equilibrio nell'inferno della mente”. Per questo mi interesso di storie e personaggi per i quali è pressoché impossibile separare l'arte dalla vita. E dunque dal loro modo di pensare. Uomini che hanno attribuito al fare musica o al dedicarsi allo strumento un'importanza quasi trascendentale, che va ben oltre il piano prettamente emozionale. Penso di nuovo a Pat Martino, che si è letteralmente ricostruito con e attraverso la chitarra dopo aver perso memoria di sé e senso d'identità, con perseveranza. O a Hendrix, le cui canzoni ancora oggi esortano a guardare il mondo da un punto di vista diverso. Chissà, forse un giorno riusciremo a farli entrare anche nelle aule scolastiche… Sono convinto che anche attraverso queste storie si possa appassionare o incuriosire ragazze e ragazzi a materie spesso giudicate troppo “astratte” come la filosofia.
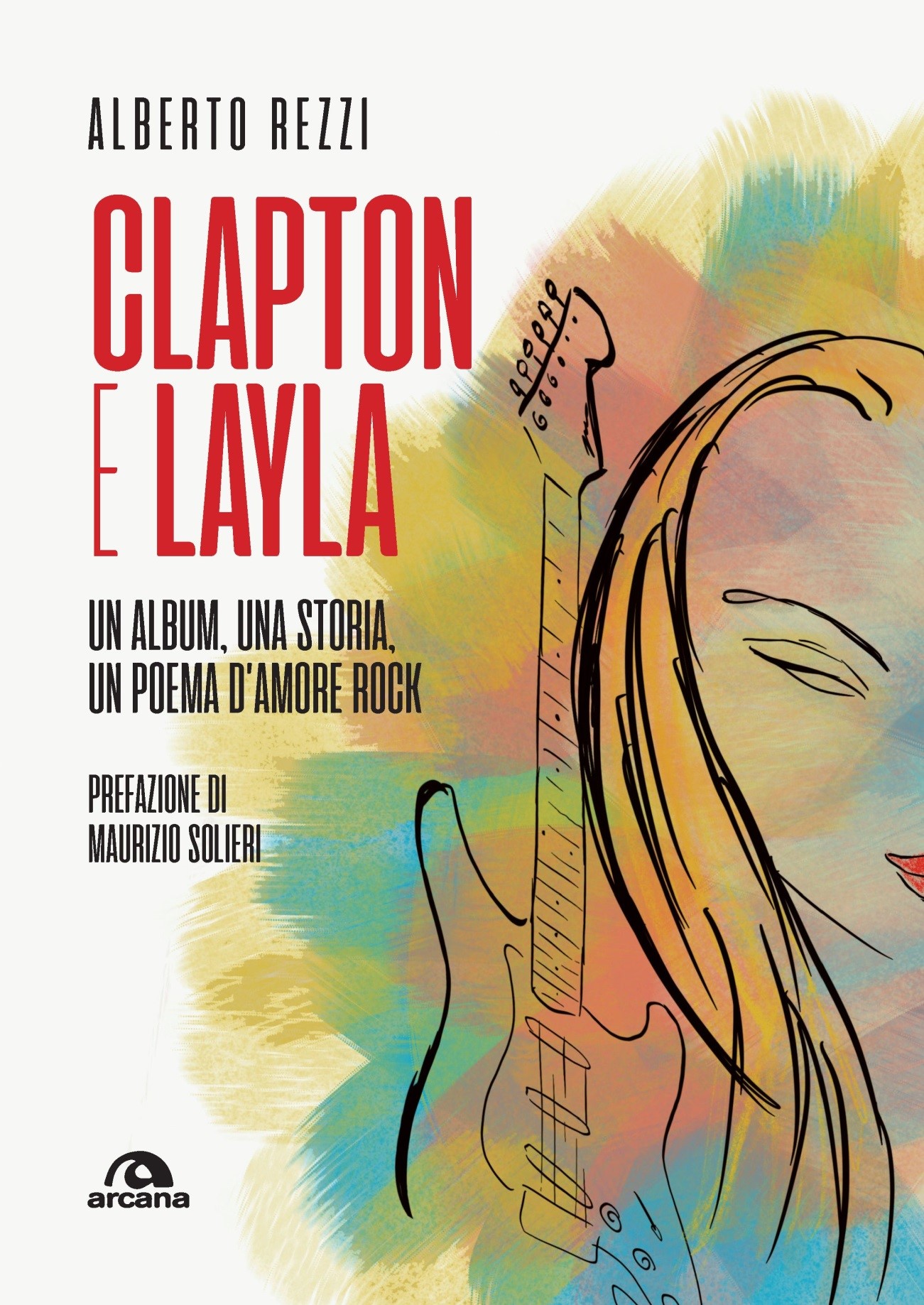
Il blues è facile – ma non semplice – da suonare, però è difficile da sentire. Jimi Hendrix nella sua variegata sperimentazione ha dimostrato di avercelo dentro e l’ha fatto confluire in nuove esperienze. Nel tuo “La filosofia di Jimi Hendrix. Viaggio al termine del mondo” lo vedi come costruttore di mondi diversi e, per certi versi, paragoni le sue scoperte alle intuizioni di Giordano Bruno e Nelson Goodman. Ascoltare un particolare tipo di musica potrebbe essere comparato a un momento catartico in cui si raggiunge una conoscenza profonda, fine ultimo della filosofia?
Jimi Hendrix è un unicum, un fuoricategoria. Una sera, davanti a una birra con un amico che insegna filosofia in uno dei licei classici più importanti di Torino, gli ho detto che da tempo mi balenava in testa l'idea di accostare Jimi a Giordano Bruno. In maniera intuitiva, senza ancora saperla esplicitare, sentivo una convergenza tra i due mondi. Qualcosa di cosmologico, se non addirittura cosmogonico. Lui non mi diede del pazzo, anzi mi esortò a seguire quella pista, e così feci.
La chitarra, i testi e la voce di Jimi mi portavano costantemente alla visione di un'infinità di mondi, non solo immaginifici, ma tutti contemporaneamente reali. Il che è proprio ciò che sta alla base del “costruzionismo” in filosofia di Nelson Goodman: tutti noi costruiamo mondi attraverso i vari linguaggi di cui disponiamo, e al di fuori di questi linguaggi non si dà “il” mondo nella sua oggettività. Tutto si gioca in questa costruzione, che è questione serissima e delicatissima, non certo un vezzo o un gioco. In questo ho trovato un'affinità di fondo tra Hendrix e Goodman, per i quali sostanzialmente la funzione dell'arte e della musica non è semplicemente quella di suscitare emozioni o generici sentimenti, ma di attivare processi di conoscenza attraverso sensi, cognizioni, esperienza, visioni.
Ho scritto il testo di getto durante il primo lockdown del 2020, e forse anche per via di quell'atmosfera mi sembrava che “viaggio al termine del mondo” fosse il sottotitolo giusto. Ma non è affatto una visione apocalittica, anzi, è semmai l'invito a seguire quello che l'arte di Jimi incarna perfettamente: a guardare oltre “il” mondo al singolare con la sua “uniforme soffocante” e percepire la possibilità di costruire e fondere mondi, ognuno nel proprio campo espressivo.
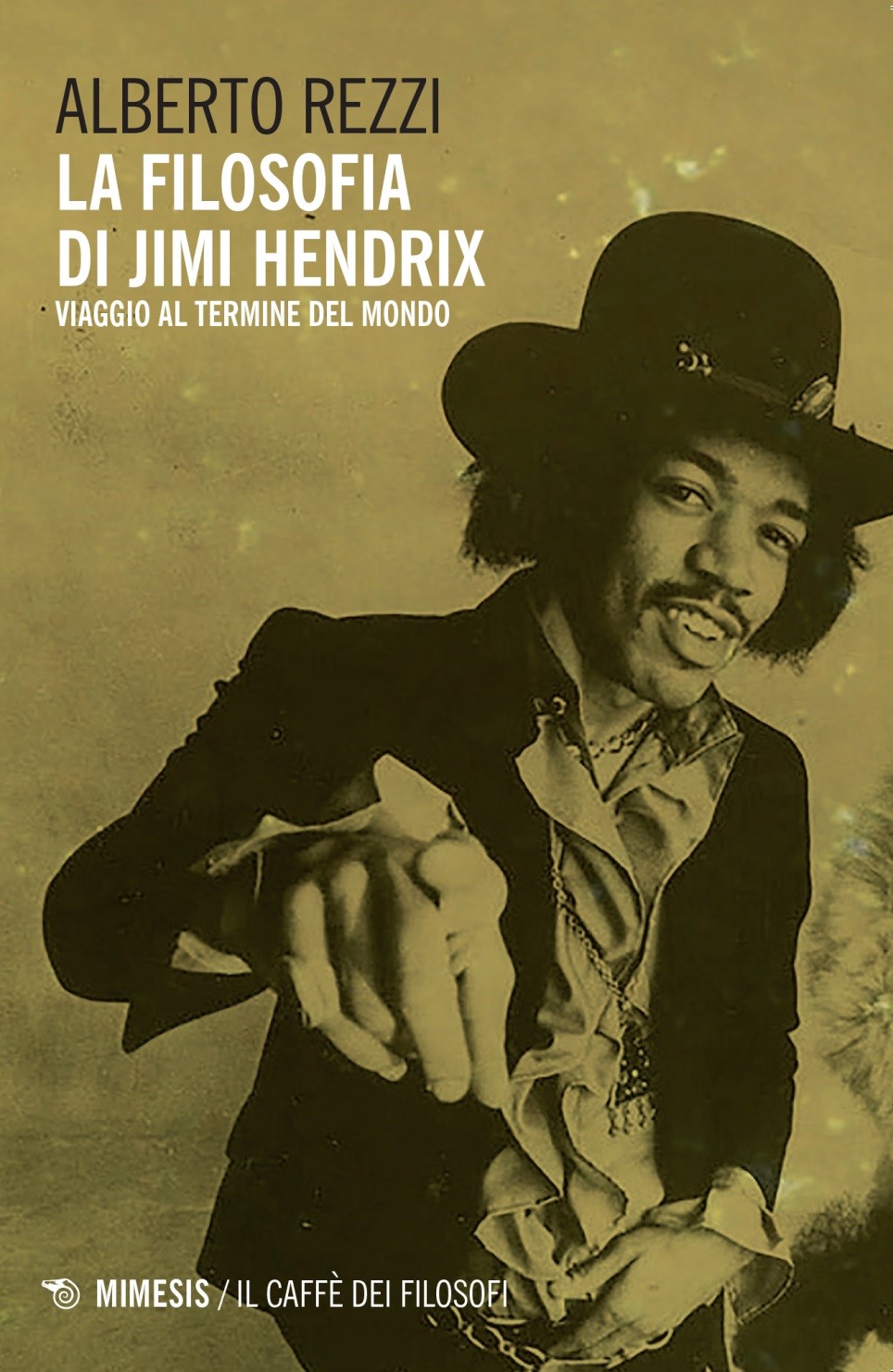
Come per Clapton non ti sei fermato a una pubblicazione, ma hai dato alla luce “L’incompiuta di Jimi Hendrix” e stavolta è stato il turno di Giuseppe Scarpato, straordinario chitarrista e compositore noto anche per la collaborazione con Edoardo Bennato, da te coinvolto in un'intervista.
Sì, proprio alla luce di quanto dicevo sul ruolo della musica per Jimi, nel suo ultimo periodo si concepiva più come un “compositore” classico che come un chitarrista e voleva mettere in musica idee che travalicavano la tastiera della sua Stratocaster. Non a caso, era impegnato nella progettazione e costruzione dei suoi avanguardistici studi di registrazione. Come sappiamo, però, la sua morte ha lasciato incompiuti moltissimi progetti e incisioni, che hanno dato vita alla pletora di pubblicazioni postume. Da qui l'idea dell'“Incompiuta”, sulla falsariga di uno Schubert.
Avevo sentito suonare Scarpato dal vivo "Purple Haze" in modo trascinante, fresco, originale, perciò mi è sembrato calzante coinvolgerlo in una vera e propria intervista che potesse approfondire anche sotto l'aspetto tecnico il lascito artistico di Jimi per i chitarristi nati dopo di lui. Anche in Scarpato ho trovato una straordinaria disponibilità e competenza: considero davvero una fortuna e un onore aver avuto la possibilità di incrociare persone come lui durante il mio percorso.
“Il rock deve creare tensioni, dubbi, interrogativi e trasmettere buone emozioni”. Perdonami la citazione, ma arriva proprio da Bennato, menzionato nella precedente domanda e altro autore italiano che ha sempre avuto spunti oltre alla classica canzonetta: ha attinto dal profondo dell’animo come George Harrison, e qui arriviamo di nuovo alla tua ultima opera, intensa e coinvolgente.
Come detto, avevo già incrociato Harrison per la stesura di Layla e analizzato a fondo il suo All Things Must Pass, riproponendomi di tornarci sopra data l'immensa ricchezza di spunti che quel disco offre a livello melodico, musicale e spirituale in senso ampio. Poi però l'idea del libro mi è nata da due letture che apparentemente nulla avevano a che fare con l'ex Beatle: Pellegrinaggio in Oriente di Hermann Hesse e Il mio Oriente di Schopenhauer. Musica, letteratura e filosofia, dunque: il comune denominatore la ricerca di quella terra del mattino, quella Inner Light che vive nascosta dietro il muro d'illusione o Maya che contraddistingue il nostro comune modo di vedere le cose, di attribuirci un'identità statica, di attaccarci a cose destinate a passare.
Harrison ha incarnato questa ricerca da quando ha scoperto, a metà anni Sessanta, l'India, la sua musica, la sua filosofia, il suo misticismo. Una ricerca sulle cui tracce mi sono messo e mosso in prima persona, perché, a differenza del modo occidentale di concepire la vita spirituale, per la visione indiana fatta propria da George tutto deve passare da un'esperienza diretta, personale. Solo questa può infatti generare un'autentica trasformazione, altrimenti preclusa ad una conoscenza astratta o puramente intellettuale. Proprio per questo coinvolgimento profondo devo ammettere che mi è stato difficile staccarmi da quel lavoro e portarlo a compimento per la pubblicazione, perché la passione che genera mettersi alla ricerca, scoprire nuove idee, trovare in grandi artisti come Harrison conferma di alcune intuizioni profonde, ma anche di fragilità e dubbi, è stata davvero un'esperienza molto coinvolgente.
Keith Richards, coetaneo di George, ha avuto sempre una filosofia più spicciola, tanto da dichiarare: “Amavo un buono sballo. E se rimani sveglio ottieni le canzoni che tutti gli altri si perdono perché stanno dormendo”. Nell’ex Beatle invece convivevano più anime, riusciva a palesarsi imperturbabile utilizzando un velo d’ironia, ma era molto combattuto dentro di sé.
Adoro Keith Richards e se si legge la sua autobiografia si comprende chiaramente di quanta sagacia, intelligenza e visione strategica sia stato dotato, al di là dell'immagine che gli è rimasta appiccicata addosso e su cui peraltro ha sapientemente giocato. George Harrison si definiva un uomo degli opposti, per questo ha lavorato per tutta la vita sulle sue contraddizioni: un altro tratto che me l'ha fatto sentire particolarmente affine. Per lui l'India e la sua cultura non sono state una moda passeggera come per molti, ma un'autentica filosofia di vita. E qui c'è molto del suo fascino: sitar, ukulele, meditazione, mantra, Ravi Shankar, corse automobilistiche, produzione cinematografica, amicizia e collaborazione con i Monty Python e poi con i Traveling Wilburys, l'amore per il giardinaggio. Dal mio punto di vista non sono esperienze contraddittorie, ma dicono molto di cosa significhi perseguire un'esistenza spirituale living in the material world. Molte sue canzoni, soprattutto da solista, riflettono costantemente questo duplice piano: melodie meravigliose, versi spesso immediatamente accessibili, ma che nascondono una chiave di lettura più profonda o allusioni a temi chiave del pensiero indiano, dall'impermanenza all'esperienza del divino, dall'illusorietà dell'io alla scoperta della vera identità.
Sbaglio nel vedere “La via mistica di George Harrison. Musica, Maya, risveglio” come, in un certo senso, la prosecuzione, molto intima e personale, del cammino iniziato con il tuo primo libro su Clapton? Ti sei talmente immedesimato nei personaggi che è come se avessi vissuto con loro, affrontando anche le asperità e ora ne sei uscito sicuramente diverso, arricchito.
Dentro tutti noi convivono diversi tratti di personalità che cerchiamo di tenere insieme, di far evolvere il più possibile in maniera armonica. A volte ci riesce, altre no. Gli artisti di cui mi sono occupato, così diversi tra loro, mi hanno attratto per determinati aspetti del loro modo di pensare, di vivere e di fare arte, ma al tempo stesso mi hanno dato l'opportunità di sondare parte di quella polivocità che ci caratterizza in quanto esseri umani. È un processo di avvicinamento e di conoscenza, più che di immedesimazione, credo.
Sono fermamente convinto, continuando a sperimentarlo in prima persona, che musica e filosofia possano essere davvero dei percorsi di liberazione: non necessariamente in senso assoluto, ma più direttamente da noi stessi, dai nostri fardelli e dai nostri attaccamenti. Aprono confini, dischiudono varchi, e in questo senso liberano portandoci a scoprire nuovi modi di vedere le cose. Anche quelle che con più facilità tendiamo a ignorare. "Art of Dying", scritta da Harrison a 26 anni, ne è un esempio nitidissimo. Come possono esserlo, su un versante solo apparentemente opposto, alcuni suoi brani intrisi di ironia e sarcasmo, come "This Song".
L’ultima domanda non può che vertere sui progetti futuri. Chi sarà il prossimo filosofo in musica? Ancora un chitarrista, vista anche la tua passione per lo strumento?
Chissà, ho sempre molte idee in testa, ma in questo momento cerco di studiare cose diverse e nutrire la mia curiosità: ad esempio, continuo ad approfondire alcuni aspetti della filosofia Vedanta, ma nel frattempo sto leggendo un libro su algoritmi e machine learning. Il tutto magari ascoltando John McLaughlin, Philip Glass, o il nostro immenso Franco Battiato. Diciamo che è tempo di semina, per il raccolto bisogna avere pazienza.
Ringrazio molto te e la redazione di Loudd per questo spazio che mi ha permesso per la prima volta di voltarmi indietro e ripensare a quanto fatto, ma che dato il mio temperamento già mi proietta al futuro con il desiderio di provare a migliorare, dentro e fuori il processo creativo.
Link:
https://www.instagram.com/rezzialberto/
https://www.mimesisedizioni.it/
http://www.arcanaedizioni.com/

